Guida per riconoscere i tuoi santi in paradiso - puntata #1
Ho visto un signore con la barba, in bicicletta, con un cartello davanti che diceva "MIND CONTROL = FASCIST NEUROLOGY", e un cartello dietro che dava in cifre la portata del problema.
Fin da quando ero piccolo (quando riflettevo terrorizzato su quanto fosse complicata la vita dei grandi) mi porto dietro il terrore latente di non riuscire a superare i requirement minimi per l'inserimento nella societa'. Non che ci pensi continuamente, ma mi torna sempre in mente con un brivido quando incrocio un barbone, o un picchiatello come il signore di cui sopra. Mi sembra sempre che quella via sia per me particolarmente dietro l'angolo (e per questo sto sempre bene attento a mettere da parte il piu' possibile di cio' che guadagno, per avere qualche anno di margine quando eventualmente arrivera' il fallimento).
E con la serie di post inaugurata la settimana scorsa vi spiego alcune cose che aiutano ad alimentare la mia paura latente.

Mio fratello fa ricerca: ogni sei mesi va in cerca di un assegno dal CNRS.
Simone Weil, citata da André Weil (il fratello di cui sopra) in Anni di apprendistato (citato da restodelmondo)
La via dell'emigrazione
In realta' avevo originariamente pianificato di parlare, in questa puntata, di cosa succede nei concorsi in Italia, ma visti i commenti al post precedente cambio l'ordine tra questa e la prossima puntata, per descrivere prima le differenze tra l'Italia e i principali paesi stranieri.

Il sistema della ricerca e' giocoforza estremamente internazionale, per cui negli anni si e' arrivati a una grandissima convergenza nei modi di assunzione in gran parte dei paesi attivi scientificamente, con le notabili eccezioni di Italia e Francia (di quest'ultima parlero' brevemente dopo) che hanno sistemi fondati su principi radicalmente diversi, probabilmente di origine napoleonica. Del sistema tedesco non so nulla, e se qualche commentatore (ne ho gia' in mente un paio) forniranno qualche dritta, linkero' il commento volentieri. [Update: Detto fatto.]
Queste modalita' sono pero' uniformi all'interno dello stesso campo, e possono essere estremamente diverse da un campo all'altro (ad esempio, per i fisici teorici e' prassi consolidata che le domande di lavoro si mandino verso la fine dell'anno solare, e che si prenda servizio circa un anno dopo; nel mio campo gli openings, cioe' le offerte di lavoro, possono uscire in qualunque momento, per prendere servizio anche la settimana dopo l'accettazione). Qui parlero' solo del mio.
Innanzitutto, va detto che gli italiani (e i francesi) sono considerati anomali per via della loro tendenza media alla fissita'. La carriera tipica di un italiano e' verticale: se in qualunque facolta' di qualunque universita' italiana interrogate i professori, sono pronto a scommettere che scoprirete che la maggioranza si sono laureati nella stessa universita' in cui insegnano.
Questa attitudine (che io stesso ho) e' ferocemente criticata nei paesi anglosassoni e nordici (e in generale in tutti i paesi che hanno adottato come modello quello anglosassone), dove e' considerato segno di prestigio il cambiare continuamente istituto e possibilmente nazione.
Io personalmente avverso fortemente questa mentalita' che premia il nomadismo (per svariati motivi che credo abbastanza ovvi - basti pensare che l'eta' "post-dottorale" e' anche l'eta' in cui normalmente le persone mettono su famiglia), trovando enormemente migliore il modello italiano. Rimango quindi sempre un po' sorpreso (e irritato) quando scopro che per moltissimi colleghi, anche italiani, il muoversi per il mondo e' addirittura uno dei benefit di questa carriera.

Comunque, le mentalita' si evolvono relativamente in fretta al mutare delle circostanze: quando ero studente io, i role model che avevo a disposizione erano persone perfettamente inquadrate nella tipica carriera verticale (dopo la laurea dottorato nella stessa universita', poi qualche anno di precariato con borse di studio o contrattini dal pretesto buffo, attesa del concorso ad hoc per loro) e chi emigrava non era quasi mai tra i bravissimi: con l'eccezione delle persone di cui sopra (cioe' quelle a cui cambiare nazione PIACE) emigravano i bravini, cioe' quelli sufficientemente bravi da vincere senza alcun problema borse o addirittura posti fissi all'estero, ma non sufficientemente bravi da convincere i loro capi italiani a investire su di loro(*).
Da quando le condizioni in Italia sono peggiorate di botto (nella ricerca ma non solo: credo che la cosa sia attribuibile in ultima analisi a un peggioramento complessivo della situazione italiana, come dimostrato dal tasso di precariato e di disperazione dei miei coetanei in generale), chi si iscrive in certe facolta', tradizionalmente orientate alla ricerca, vede i suoi role model in difficolta' e sempre piu' spesso emigranti, ed e' quindi piu' facile che entri in un'ordine di idee in cui questa e' la normalita'. Tra quando uno studente si iscrive e quando si laurea, ha fatto in tempo a ricevere il messaggio che fare ricerca significa molto spesso emigrare, mentre per quelli della generazione di transizione cui io appartengo fu uno choc.
Ma come funziona all'estero? (Da qui in poi, sottintendo con questa parola quella maggioranza di paesi scientificamente evoluti che si sono dotati di un sistema simile a quello anglosassone.)
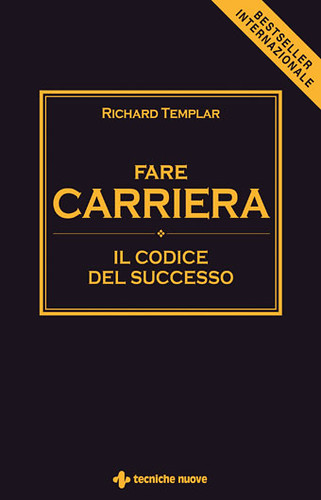
Il posto fisso solitamente lo si ottiene attorno ai 35 anni, con variabilita' tra i 30 e i 40. Quindi, fino a un decennio fa l'Italia era nota come un paese dalla carriera rapidissima (come la Francia tuttora), ma c'e' un ma. In Italia e Francia, che hanno un'intera societa' tradizionalmente basata sul posto fisso, il primo gradino fisso di carriera (in Italia, nell'universita', chiamato Ricercatore) e' sempre stato considerato un posto da bassa manovalanza, pagato poco e con zero potere. Altrove il posto fisso invece e' qualcosa di molto prestigioso, e di solito porta con se' la possibilita' di formare un proprio gruppo di ricerca (diventando responsabile di dottorandi, e in alcuni casi con un piccolo budget per bandire borse post-doc, vedi sotto).
Questo perche' prima del posto fisso c'e' il gradino del post-doc, che ha a sua volta un prestigio maggiore dell'equivalente italiano (l'Assegno di ricerca, che a sua volta e' un'introduzione abbastanza recente, motivata dall'allungamento dei periodi di precariato tra il dottorato e il posto fisso, e il cui prestigio nella stessa Italia e' pressocche' nullo). La durata standard di un post-doc e' due anni, piu' raramente tre, ed e' molto raro (e malvisto) che si rimanga nella stessa sede per due post-doc consecutivi. Se sei bravo sarebbe negli interessi dei tuoi datori di lavoro tenerti, ovviamente, ma a quanto pare viene poi considerato come una chiazza scura sul tuo curriculum (ovvero: perche' e' rimasto li'? non ha ricevuto offerte migliori altrove?), quindi conviene farlo solo se c'e' un salto di qualita' tra il primo e il secondo contratto (ovvero, se il primo e' un normale post-doc, il secondo come minimo deve essere un titolo piu' altisonante, ancorche' precario anch'esso).
Modalita' di assunzione dei post-doc: bizzarramente, l'unico grosso elemento di variabilita' e' l'esistenza o no dell'interview, cioe' il colloquio di assunzione. Per quanto incredibile possa sembrare, molto spesso si puo' essere presi per lavorare due anni in un posto senza nemmeno fare un colloquio.
Il motivo per cui nonostante tutto la cosa sembra funzionare e' che e' comunque prassi da parte dei datori di lavoro (che ci sia o no il colloquio) fare delle inchieste private, telefonando qua e la' per sapere dalla gente cosa pensa dei vari candidati. (Questo porta a premiare la visibilita', ovvero il fare presentazioni il piu' spesso possibile a meeting internazionali e conferenze, anche quando non si ha nulla di realmente nuovo da presentare, mentre il sistema italiano, dove la tua carriera dipende solo dall'opinione che ha di te una singola persona, che e' il tuo padrino, non porta la gente a sentire la cosa come molto rilevante, e come comportamento patologico induce semmai al leccaculismo. Ad esempio, per un precario italiano e' un comportamento razionale fare esercitazioni gratis per il corso del suo professore, anche se non e' pagato e non e' neanche riconosciuto ufficialmente dall'universita' e quindi non puo' nemmeno scriverlo nel curriculum, mentre per un post-doc straniero e' impensabile fare didattica - nemmeno se riconosciuto ufficialmente - perche' sottrae ore preziose alla ricerca, che e' l'unica attivita' che gli da' visibilita'.)
Quando si fa domanda per un post-doc le cose piu' importanti sono il curriculum e le lettere di presentazione.
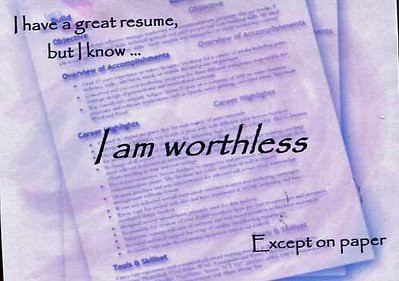
Per il curriculum, niente di particolarmente strano: si cerca di fare i grossi, e di sopprimere la naturale tendenza, che tutti impariamo fin dal primo impatto nel vivere civile, ad avere decenza.
La differenza col mondo privato e' che i CV sintetici, bullet dopo bullet solo le info essenziali, non sono apprezzati. Ogni volta che faccio leggere il mio CV a qualcuno per dei consigli, mi e' sempre stato consigliato di essere piu' dettagliato, piu' magniloquente, piu' superfluo. Il mio CV attuale e' 10 pagine (e per decenza ho usato un font piccolo) e non e' tra i piu' lunghi.
La differenza col mondo dei concorsi in Italia e' che in Italia, tanto, i CV non servono a niente e quindi nessuno ci perde troppo tempo. O meglio, c'e' una cosa a cui servono: illustrare alla commissione su cos'e' che hai competenze. Quindi, siccome i commissari hanno interesse a demolire i candidati che non vogliono far vincere e far apparire che sono degli ignoranti immeritevoli, usano l'informazione del CV per capire su cosa certamente non sei competente, e su cui quindi insistere nel farti domande dettagliate (si ha quindi il paradosso che da un lato ti conviene elencare tutto nel CV perche' fa parte della valutazione, dall'altro gli fornisci gli strumenti per la tua stessa rovina). Ma di questo parlero' con piu' dettagli nella prossima puntata.

Le lettere di raccomandazione, a quanto pare, sono importantissime.
In ogni bando all'estero, sia per post-doc che per posto fisso (ma anche per l'ammissione al dottorato), sono richieste un tot di lettere di raccomandazione, variabile tra una e tre (ma di solito e' consentito spedirne piu' del numero indicato dal bando).
Una lettera di raccomandazione e' scritta da qualcuno con cui hai lavorato che testimonia di conoscerti e di stimarti molto.
O meglio, potrebbe anche parlare male di te, e per questo teoricamente la lettera e' segreta e il candidato non e' autorizzato a conoscerne il contenuto. I professori italiani di solito pero' non si fanno problemi a farla leggere alla persona per cui la stanno scrivendo (di solito per fargli vedere quanto lo stanno lodando, altre volte c'e' un motivo pratico: non si ricordano esattamente le cose che ha fatto, e quindi vogliono evitare gaffe rivelatrici nell'elogiarlo per averle fatte; mi e' capitato di dettare un paragrafo di una delle mie lettere di raccomandazione...), e idem anche alcuni stranieri. Ma puo' capitare che alcune lettere parlino male del candidato! E' molto raro (ed e' considerato molto da stronzi, ovviamente: il modo corretto di comportarsi, secondo le regole condivise dalla comunita', e' dire che si preferisce non scrivere la lettera), ma conosco due casi certificati in cui cio' e' capitato, che ovviamente vengono tramandati oralmente da generazioni.
Uno dei motivi per cui un professore puo' parlare male di un candidato in una lettera che idealmente dovrebbe aiutarlo e' che effettivamente lo disprezzi (a sua insaputa) e ritenga sia un bene per la comunita' scientifica che la sua scarsezza, non necessariamente evidente dal curriculum, sia nota a tutti. Un altro motivo puo' essere che nello stesso opening abbiano fatto domanda piu' persone che gli hanno chiesto la lettera, e lui abbia le idee chiare su chi meriti maggiormente, e quindi faccia lettere di tenore diverso per comunicare al comitato di selezione la sua personale graduatoria di merito.
Pare, ma non ho esperienza diretta, che nel sistema tedesco sia prassi che anche per i candidati piu' lodevoli siano indicati i difetti [Update: Delio smentisce]. Da cui l'aneddoto secondo cui Pauli, nello scrivere la lettera di raccomandazione per un suo brillante ex allievo (diverse versioni dello stesso aneddoto forniscono un nome diverso all'ex allievo) che faceva domanda per Princeton, per lavorare con Einstein, concluse con "il suo unico difetto e' che tende a perdere di vista il senso fisico a favore dell'astrattezza matematica - ma non credo che per lei sia un grosso problema, Prof. Einstein".
Tuttora, i professori tedeschi hanno fama di scrivere lettere poco entusiastiche anche per i migliori.
I professori italiani invece si sbracano sistematicamente per qualunque candidato, ma sono internazionalmente ben noti per questo e i selezionatori ne tengono conto.
Gli americani si sbracano enormemente per i migliori soltanto. E sono noti per una cosa che tutti gli europei trovano unanimemente ripugnante: nella lettera di raccomandazione per un candidato, sono soliti fare paragoni diretti (a suo favore) tra il candidato e altri colleghi dello stesso ambiente e della stessa fascia d'eta' (quindi potenziali diretti concorrenti, o persone che di recente hanno vinto un posto di prestigio simile o superiore).
La lettera viene valutata in base al contenuto ma ovviamente conta tantissimo l'importanza di chi l'ha scritta. Per cui ogni volta che si fa domanda per un posto, si perde un bel po' di tempo e di benessere mentale a esplorare tutte le opzioni: conviene chiedere al professorone mega-importante che ti fa una lettera freddina (o peggio ancora la fa anche a qualche altro candidato e la fa piu' entusiastica che a te) o a quello meno noto che pero' ti conosce meglio, ti stima di piu', magari ha piu' complicita' con te?
Non e' mai una scelta facile, ma c'e' anche un altro fattore: e' matematico che chiunque ti dica "si', ti faccio la lettera, non c'e' problema, dammi l'indirizzo a cui mandarla" se ne dimentichera'. Per quanto ti voglia bene, sarai costretto a ricordarglielo.
Non c'e' chiaramente un problema quando sei in stretti rapporti con la persona a cui hai chiesto la lettera, a parte casi in cui diventa irreperibile senza dire quando tornera', ma la cosa diventa piuttosto sgradevole quando non lo sei, e questa persona e' molto importante e, come tutte le persone importanti, e' anche molto impegnata.
(Io in particolare ho serissimi problemi a chiedere favori, anche fuori da questo ambito, e anche serissimi problemi a ricordare alle persone che mi avevano promesso qualcosa. La tensione della deadline che si avvicina e delle mie lettere di raccomandazione che non partono nonostante un paio di solleciti e', tra le stazioni della mia via crucis precaria, una di quelle che piu' ricordero' con orrore quando l'incubo sara' eventualmente finito.)
Una volta che feci domanda per un posto fisso, sempre per la logica del chiedere la lettera a qualcuno non importantissimo ma che conosce bene il mio lavoro e certamente mi stima, pensai di chiederla a un collega (straniero) che, avevo notato, da qualche tempo era diventato Professore.
Glielo chiesi via mail, e lui rispose dopo un po' (doveva averci riflettuto molto) dicendo che era molto onorato della richiesta e per lui non c'erano problemi, ma per correttezza ci teneva a dirmi che stava facendo domanda per lo stesso posto, e insomma stava a me decidere se per me era un problema dato che eravamo in concorrenza.
Venne fuori insomma che il titolo di Professore di cui pomposamente aveva iniziato a fregiarsi in ogni occasione in cui fosse decente farlo era, in realta', un posto da professore a contratto. Piu' prestigioso di quel che sono io, ma pur sempre un precario.
Fine parentesi lollosa. (Ne' io ne' lui fummo minimamente presi in considerazione per quel posto.)
Quando c'e' l'interview (per i posti fissi c'e' sempre), la cosa verte sulla propria attivita' di ricerca passata e su quello che si vorrebbe fare nel futuro. La cosa sembrera' ovvia a chi lavora nel privato, ma e' sempre sorprendente per chi viene dal mondo della ricerca italiana.
In Italia infatti i concorsi (per il posto da ricercatore si tratta di due scritti e un orale, oppure scritto, prova pratica in laboratorio, orale) vertono sulla conoscenza di base del candidato, piu' parte dell'orale dedicata alla descrizione della sua ricerca in corso (che pero' deve essere usata come punto di partenza per altre domande di conoscenza generale del campo). Sono rari i posti per discipline specifiche e piu' frequenti quelli per classi concorsuali molto generiche, come "fisica generale" (per il motivo di base che le universita' hanno un fabbisogno maggiore di persone che insegnino materie comuni a piu' facolta', e piu' popolose, e fisica generale e' insegnata in tutti i corsi di laurea scientifici mentre "fisica delle particelle" no). Di conseguenza, a ogni concorso ogni candidato che non voglia fare brutta figura passa un paio di mesi a ripassare concetti di base di primo o secondo anno d'universita'(**). Siccome questo sottrae tempo al lavoro vero, solitamente i datori di lavoro stranieri non apprezzano moltissimo (e non conoscendo il sistema non lo capiscono).
In Italia il sistema e' pensato in un modo che io trovo ideale, per vari motivi, e che e' tradito. Il legislatore si e' impegnato nel rendere il concorso il piu' blind possibile: durante gli scritti, tutti i candidati devono essere anonimi (scrivono i nomi in una busta piccola, da inserire nella busta grande con l'elaborato, che sara' aperta solo dopo la correzione); devono usare penne identiche, fornite dai commissari; se un candidato chiede un foglio in piu', tutti i candidati devono avere fogli in piu'; qualunque segno strano sui fogli puo' essere causa di esclusione, se ci sono motivi fondati di ritenere che sia un messaggio in codice per farsi identificare da un commissario; all'orale, idealmente (ma non nella pratica) le domande dovrebbero essere il meno ad hoc possibile, con l'unica eccezione del momento in cui il candidato deve descrivere la sua attivita' in corso; ma soprattutto, la valutazione non puo' essere basata sul tipo di ricerca in corso o passata, perche' non bisogna avvantaggiare chi lavora con qualcuno piuttosto che con qualcun altro. E invece, l'intera essenza (reale) del sistema di selezione italiano e' basato sul lavorare con le persone giuste.
Chi e' esterno al sistema, o e' interno ma intravede che potrebbe beneficiarne, tende a dire che tutto sommato gli sembra giusto: nel settore privato si sceglie ad personam, anche nella ricerca all'estero si sceglie ad personam, ed e' semmai il meccanismo del concorso ad essere anacronistico e inadatto. Se i concorsi italiani seguono criteri di giudizio arbitrari poco importa, visto che tutto il mondo e' arbitrario.
Ci sono pero' due problemi:
- Primo problema: il sistema e' ipocrita. E uno puo' dire ok, il sistema e' ipocrita, e allora? E allora, questo ha anche conseguenze pratiche a mio avviso: all'estero o nel privato, la valutazione e' arbitraria ma trasparentemente arbitraria: chi assume qualcuno se ne prende la responsabilita' (e di solito anche l'onere, ovvero lo stipendio del neoassunto proviene da fondi assegnati alla persona che lo ha scelto, mentre in Italia lo stipendio viene erogato centralmente). Le degenerazioni descritte nella prima nota di questo post sono possibili solo in un sistema in cui chi seleziona non riceve danni da una sua cattiva scelta, come appunto in Italia.
- Il secondo problema e' che, a mio avviso, il concorso blind all'italiana sarebbe davvero una ottima idea, se applicata realmente. La scienza e' tanto piu' a rischio di conformismo quanto piu' i selezionatori valutano i candidati in base a cio' su cui lavorano. Una ricerca "eretica" o semplicemente fuori moda e' possibile solo da parte di chi ha un posto fisso e non ha quindi nulla di serio da perdere. Un precario, ovviamente, ha tante piu' opportunita' di lavoro quanto piu' fa ricerca alla moda. Considerata la celebre curva di produttivita' che ha il suo picco attorno ai 30 anni, e il fatto che lo standard mondiale e' essere post-doc fino a 35 anni in media, e' facile trarne conclusioni. (Infatti i posti fissi contemplano solitamente doveri didattici e anche di amministrazione, e doveri impliciti di coordinamento del lavoro altrui, perche' non ci si aspetta che si lavori davvero, ci si aspetta che si sia dei leader.)

Testi e note:
(*) Altra specificita' del mio campo: pur essendo mafiosissimo, ma lo sono tutte le discipline indifferentemente in Italia, e' anche meritocratico. E' estremamente raro che chi raggiunge l'agognato posto fisso non sia molto bravo (anche se non e' necessariamente il PIU' bravo, e quando capita che lo sia e' comunque un caso). Infatti, anche se nei concorsi il merito non ha di fatto alcun ruolo (contano solo le alternanze tra gruppi afferenti alle diverse baronie), durante gli anni del precariato la scrematura e' abbastanza severa, perche' i padrini universitari hanno fondi limitati e tutto l'interesse a tenere solo quelli che valgono la pena.
Uno dei motivi per cui in altri campi sia normale che i favoritismi siano per parenti e amanti dei baroni (e, in subordine, per chiunque capiti nella coorte, foss'anche un ex laureando un po' scemo) e in altri campi siano prevalenti i sani interessi del gruppo e' probabilmente attribuibile alla diversa internazionalizzazione tra le diverse discipline. Quando sei in competizione con gruppi stranieri, come nella maggior parte delle discipline scientifiche, stai ben attento a non promuovere imbecilli. Quando invece ti interessa solo il potere locale, far diventare senatore un cavallo fa risaltare maggiormente la tua arroganza e, quindi, incute in tutti rispetto per il tuo Potere.
(**) Mi e' capitato di recente che una collega piu' grande, diventata ricercatrice quando io ero ancora studente, mentre le spiegavo una cosa che aveva radici in una nozione abbastanza "da pivelli" da poter essere dimenticata negli anni, dicesse per giustificarsi "eh, queste cose le ho studiate l'ultima volta per il concorso e poi basta piu'!", lasciandomi di sasso perche' sottintendeva che aveva fatto un solo concorso nella sua vita, quello che aveva vinto. Io, per non farla sentire a disagio per la sua ignoranza di quel concetto, dissi invece "be', io invece me lo ricordo bene perche' faccio in media due concorsi l'anno", mettendola in imbarazzo. (Se mi leggi: non era mia intenzione, volevo solo sdrammatizzare.)
(Incidentalmente, sul tema della precarieta' vi segnalo "La rivoluzione precaria - La lotta dei giovani francesi contro il CPE", di Antonio Sciotto e Anna Maria Merlo, donatomi da uno degli autori che qui ringrazio. Parla del caso francese, ma esso e' sufficientemente simile a quello italiano da permettere paragoni sensati e fare insomma capire che ci stiamo dirigendo verso la catastrofe e non c'e' proprio nulla da fare.)
Fin da quando ero piccolo (quando riflettevo terrorizzato su quanto fosse complicata la vita dei grandi) mi porto dietro il terrore latente di non riuscire a superare i requirement minimi per l'inserimento nella societa'. Non che ci pensi continuamente, ma mi torna sempre in mente con un brivido quando incrocio un barbone, o un picchiatello come il signore di cui sopra. Mi sembra sempre che quella via sia per me particolarmente dietro l'angolo (e per questo sto sempre bene attento a mettere da parte il piu' possibile di cio' che guadagno, per avere qualche anno di margine quando eventualmente arrivera' il fallimento).
E con la serie di post inaugurata la settimana scorsa vi spiego alcune cose che aiutano ad alimentare la mia paura latente.

Mio fratello fa ricerca: ogni sei mesi va in cerca di un assegno dal CNRS.
Simone Weil, citata da André Weil (il fratello di cui sopra) in Anni di apprendistato (citato da restodelmondo)
La via dell'emigrazione
In realta' avevo originariamente pianificato di parlare, in questa puntata, di cosa succede nei concorsi in Italia, ma visti i commenti al post precedente cambio l'ordine tra questa e la prossima puntata, per descrivere prima le differenze tra l'Italia e i principali paesi stranieri.

Il sistema della ricerca e' giocoforza estremamente internazionale, per cui negli anni si e' arrivati a una grandissima convergenza nei modi di assunzione in gran parte dei paesi attivi scientificamente, con le notabili eccezioni di Italia e Francia (di quest'ultima parlero' brevemente dopo) che hanno sistemi fondati su principi radicalmente diversi, probabilmente di origine napoleonica. Del sistema tedesco non so nulla, e se qualche commentatore (ne ho gia' in mente un paio) forniranno qualche dritta, linkero' il commento volentieri. [Update: Detto fatto.]
Queste modalita' sono pero' uniformi all'interno dello stesso campo, e possono essere estremamente diverse da un campo all'altro (ad esempio, per i fisici teorici e' prassi consolidata che le domande di lavoro si mandino verso la fine dell'anno solare, e che si prenda servizio circa un anno dopo; nel mio campo gli openings, cioe' le offerte di lavoro, possono uscire in qualunque momento, per prendere servizio anche la settimana dopo l'accettazione). Qui parlero' solo del mio.
Innanzitutto, va detto che gli italiani (e i francesi) sono considerati anomali per via della loro tendenza media alla fissita'. La carriera tipica di un italiano e' verticale: se in qualunque facolta' di qualunque universita' italiana interrogate i professori, sono pronto a scommettere che scoprirete che la maggioranza si sono laureati nella stessa universita' in cui insegnano.
Questa attitudine (che io stesso ho) e' ferocemente criticata nei paesi anglosassoni e nordici (e in generale in tutti i paesi che hanno adottato come modello quello anglosassone), dove e' considerato segno di prestigio il cambiare continuamente istituto e possibilmente nazione.
Io personalmente avverso fortemente questa mentalita' che premia il nomadismo (per svariati motivi che credo abbastanza ovvi - basti pensare che l'eta' "post-dottorale" e' anche l'eta' in cui normalmente le persone mettono su famiglia), trovando enormemente migliore il modello italiano. Rimango quindi sempre un po' sorpreso (e irritato) quando scopro che per moltissimi colleghi, anche italiani, il muoversi per il mondo e' addirittura uno dei benefit di questa carriera.

Comunque, le mentalita' si evolvono relativamente in fretta al mutare delle circostanze: quando ero studente io, i role model che avevo a disposizione erano persone perfettamente inquadrate nella tipica carriera verticale (dopo la laurea dottorato nella stessa universita', poi qualche anno di precariato con borse di studio o contrattini dal pretesto buffo, attesa del concorso ad hoc per loro) e chi emigrava non era quasi mai tra i bravissimi: con l'eccezione delle persone di cui sopra (cioe' quelle a cui cambiare nazione PIACE) emigravano i bravini, cioe' quelli sufficientemente bravi da vincere senza alcun problema borse o addirittura posti fissi all'estero, ma non sufficientemente bravi da convincere i loro capi italiani a investire su di loro(*).
Da quando le condizioni in Italia sono peggiorate di botto (nella ricerca ma non solo: credo che la cosa sia attribuibile in ultima analisi a un peggioramento complessivo della situazione italiana, come dimostrato dal tasso di precariato e di disperazione dei miei coetanei in generale), chi si iscrive in certe facolta', tradizionalmente orientate alla ricerca, vede i suoi role model in difficolta' e sempre piu' spesso emigranti, ed e' quindi piu' facile che entri in un'ordine di idee in cui questa e' la normalita'. Tra quando uno studente si iscrive e quando si laurea, ha fatto in tempo a ricevere il messaggio che fare ricerca significa molto spesso emigrare, mentre per quelli della generazione di transizione cui io appartengo fu uno choc.
Ma come funziona all'estero? (Da qui in poi, sottintendo con questa parola quella maggioranza di paesi scientificamente evoluti che si sono dotati di un sistema simile a quello anglosassone.)
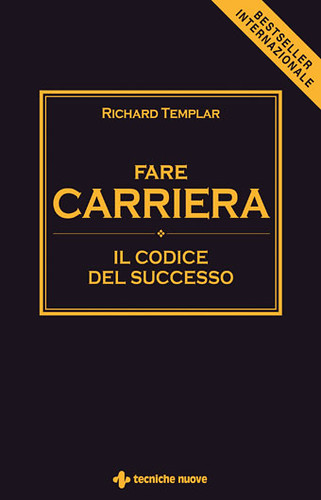
Il posto fisso solitamente lo si ottiene attorno ai 35 anni, con variabilita' tra i 30 e i 40. Quindi, fino a un decennio fa l'Italia era nota come un paese dalla carriera rapidissima (come la Francia tuttora), ma c'e' un ma. In Italia e Francia, che hanno un'intera societa' tradizionalmente basata sul posto fisso, il primo gradino fisso di carriera (in Italia, nell'universita', chiamato Ricercatore) e' sempre stato considerato un posto da bassa manovalanza, pagato poco e con zero potere. Altrove il posto fisso invece e' qualcosa di molto prestigioso, e di solito porta con se' la possibilita' di formare un proprio gruppo di ricerca (diventando responsabile di dottorandi, e in alcuni casi con un piccolo budget per bandire borse post-doc, vedi sotto).
Questo perche' prima del posto fisso c'e' il gradino del post-doc, che ha a sua volta un prestigio maggiore dell'equivalente italiano (l'Assegno di ricerca, che a sua volta e' un'introduzione abbastanza recente, motivata dall'allungamento dei periodi di precariato tra il dottorato e il posto fisso, e il cui prestigio nella stessa Italia e' pressocche' nullo). La durata standard di un post-doc e' due anni, piu' raramente tre, ed e' molto raro (e malvisto) che si rimanga nella stessa sede per due post-doc consecutivi. Se sei bravo sarebbe negli interessi dei tuoi datori di lavoro tenerti, ovviamente, ma a quanto pare viene poi considerato come una chiazza scura sul tuo curriculum (ovvero: perche' e' rimasto li'? non ha ricevuto offerte migliori altrove?), quindi conviene farlo solo se c'e' un salto di qualita' tra il primo e il secondo contratto (ovvero, se il primo e' un normale post-doc, il secondo come minimo deve essere un titolo piu' altisonante, ancorche' precario anch'esso).
Modalita' di assunzione dei post-doc: bizzarramente, l'unico grosso elemento di variabilita' e' l'esistenza o no dell'interview, cioe' il colloquio di assunzione. Per quanto incredibile possa sembrare, molto spesso si puo' essere presi per lavorare due anni in un posto senza nemmeno fare un colloquio.
Il motivo per cui nonostante tutto la cosa sembra funzionare e' che e' comunque prassi da parte dei datori di lavoro (che ci sia o no il colloquio) fare delle inchieste private, telefonando qua e la' per sapere dalla gente cosa pensa dei vari candidati. (Questo porta a premiare la visibilita', ovvero il fare presentazioni il piu' spesso possibile a meeting internazionali e conferenze, anche quando non si ha nulla di realmente nuovo da presentare, mentre il sistema italiano, dove la tua carriera dipende solo dall'opinione che ha di te una singola persona, che e' il tuo padrino, non porta la gente a sentire la cosa come molto rilevante, e come comportamento patologico induce semmai al leccaculismo. Ad esempio, per un precario italiano e' un comportamento razionale fare esercitazioni gratis per il corso del suo professore, anche se non e' pagato e non e' neanche riconosciuto ufficialmente dall'universita' e quindi non puo' nemmeno scriverlo nel curriculum, mentre per un post-doc straniero e' impensabile fare didattica - nemmeno se riconosciuto ufficialmente - perche' sottrae ore preziose alla ricerca, che e' l'unica attivita' che gli da' visibilita'.)
Quando si fa domanda per un post-doc le cose piu' importanti sono il curriculum e le lettere di presentazione.
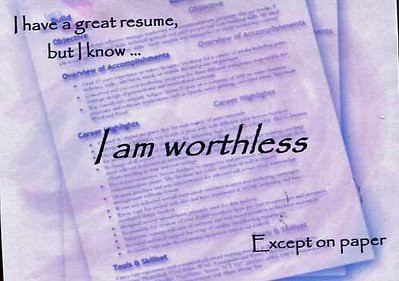
Per il curriculum, niente di particolarmente strano: si cerca di fare i grossi, e di sopprimere la naturale tendenza, che tutti impariamo fin dal primo impatto nel vivere civile, ad avere decenza.
La differenza col mondo privato e' che i CV sintetici, bullet dopo bullet solo le info essenziali, non sono apprezzati. Ogni volta che faccio leggere il mio CV a qualcuno per dei consigli, mi e' sempre stato consigliato di essere piu' dettagliato, piu' magniloquente, piu' superfluo. Il mio CV attuale e' 10 pagine (e per decenza ho usato un font piccolo) e non e' tra i piu' lunghi.
La differenza col mondo dei concorsi in Italia e' che in Italia, tanto, i CV non servono a niente e quindi nessuno ci perde troppo tempo. O meglio, c'e' una cosa a cui servono: illustrare alla commissione su cos'e' che hai competenze. Quindi, siccome i commissari hanno interesse a demolire i candidati che non vogliono far vincere e far apparire che sono degli ignoranti immeritevoli, usano l'informazione del CV per capire su cosa certamente non sei competente, e su cui quindi insistere nel farti domande dettagliate (si ha quindi il paradosso che da un lato ti conviene elencare tutto nel CV perche' fa parte della valutazione, dall'altro gli fornisci gli strumenti per la tua stessa rovina). Ma di questo parlero' con piu' dettagli nella prossima puntata.

Le lettere di raccomandazione, a quanto pare, sono importantissime.
In ogni bando all'estero, sia per post-doc che per posto fisso (ma anche per l'ammissione al dottorato), sono richieste un tot di lettere di raccomandazione, variabile tra una e tre (ma di solito e' consentito spedirne piu' del numero indicato dal bando).
Una lettera di raccomandazione e' scritta da qualcuno con cui hai lavorato che testimonia di conoscerti e di stimarti molto.
O meglio, potrebbe anche parlare male di te, e per questo teoricamente la lettera e' segreta e il candidato non e' autorizzato a conoscerne il contenuto. I professori italiani di solito pero' non si fanno problemi a farla leggere alla persona per cui la stanno scrivendo (di solito per fargli vedere quanto lo stanno lodando, altre volte c'e' un motivo pratico: non si ricordano esattamente le cose che ha fatto, e quindi vogliono evitare gaffe rivelatrici nell'elogiarlo per averle fatte; mi e' capitato di dettare un paragrafo di una delle mie lettere di raccomandazione...), e idem anche alcuni stranieri. Ma puo' capitare che alcune lettere parlino male del candidato! E' molto raro (ed e' considerato molto da stronzi, ovviamente: il modo corretto di comportarsi, secondo le regole condivise dalla comunita', e' dire che si preferisce non scrivere la lettera), ma conosco due casi certificati in cui cio' e' capitato, che ovviamente vengono tramandati oralmente da generazioni.
Uno dei motivi per cui un professore puo' parlare male di un candidato in una lettera che idealmente dovrebbe aiutarlo e' che effettivamente lo disprezzi (a sua insaputa) e ritenga sia un bene per la comunita' scientifica che la sua scarsezza, non necessariamente evidente dal curriculum, sia nota a tutti. Un altro motivo puo' essere che nello stesso opening abbiano fatto domanda piu' persone che gli hanno chiesto la lettera, e lui abbia le idee chiare su chi meriti maggiormente, e quindi faccia lettere di tenore diverso per comunicare al comitato di selezione la sua personale graduatoria di merito.
Pare, ma non ho esperienza diretta, che nel sistema tedesco sia prassi che anche per i candidati piu' lodevoli siano indicati i difetti [Update: Delio smentisce]. Da cui l'aneddoto secondo cui Pauli, nello scrivere la lettera di raccomandazione per un suo brillante ex allievo (diverse versioni dello stesso aneddoto forniscono un nome diverso all'ex allievo) che faceva domanda per Princeton, per lavorare con Einstein, concluse con "il suo unico difetto e' che tende a perdere di vista il senso fisico a favore dell'astrattezza matematica - ma non credo che per lei sia un grosso problema, Prof. Einstein".
Tuttora, i professori tedeschi hanno fama di scrivere lettere poco entusiastiche anche per i migliori.
I professori italiani invece si sbracano sistematicamente per qualunque candidato, ma sono internazionalmente ben noti per questo e i selezionatori ne tengono conto.
Gli americani si sbracano enormemente per i migliori soltanto. E sono noti per una cosa che tutti gli europei trovano unanimemente ripugnante: nella lettera di raccomandazione per un candidato, sono soliti fare paragoni diretti (a suo favore) tra il candidato e altri colleghi dello stesso ambiente e della stessa fascia d'eta' (quindi potenziali diretti concorrenti, o persone che di recente hanno vinto un posto di prestigio simile o superiore).
La lettera viene valutata in base al contenuto ma ovviamente conta tantissimo l'importanza di chi l'ha scritta. Per cui ogni volta che si fa domanda per un posto, si perde un bel po' di tempo e di benessere mentale a esplorare tutte le opzioni: conviene chiedere al professorone mega-importante che ti fa una lettera freddina (o peggio ancora la fa anche a qualche altro candidato e la fa piu' entusiastica che a te) o a quello meno noto che pero' ti conosce meglio, ti stima di piu', magari ha piu' complicita' con te?
Non e' mai una scelta facile, ma c'e' anche un altro fattore: e' matematico che chiunque ti dica "si', ti faccio la lettera, non c'e' problema, dammi l'indirizzo a cui mandarla" se ne dimentichera'. Per quanto ti voglia bene, sarai costretto a ricordarglielo.
Non c'e' chiaramente un problema quando sei in stretti rapporti con la persona a cui hai chiesto la lettera, a parte casi in cui diventa irreperibile senza dire quando tornera', ma la cosa diventa piuttosto sgradevole quando non lo sei, e questa persona e' molto importante e, come tutte le persone importanti, e' anche molto impegnata.
(Io in particolare ho serissimi problemi a chiedere favori, anche fuori da questo ambito, e anche serissimi problemi a ricordare alle persone che mi avevano promesso qualcosa. La tensione della deadline che si avvicina e delle mie lettere di raccomandazione che non partono nonostante un paio di solleciti e', tra le stazioni della mia via crucis precaria, una di quelle che piu' ricordero' con orrore quando l'incubo sara' eventualmente finito.)
Una volta che feci domanda per un posto fisso, sempre per la logica del chiedere la lettera a qualcuno non importantissimo ma che conosce bene il mio lavoro e certamente mi stima, pensai di chiederla a un collega (straniero) che, avevo notato, da qualche tempo era diventato Professore.
Glielo chiesi via mail, e lui rispose dopo un po' (doveva averci riflettuto molto) dicendo che era molto onorato della richiesta e per lui non c'erano problemi, ma per correttezza ci teneva a dirmi che stava facendo domanda per lo stesso posto, e insomma stava a me decidere se per me era un problema dato che eravamo in concorrenza.
Venne fuori insomma che il titolo di Professore di cui pomposamente aveva iniziato a fregiarsi in ogni occasione in cui fosse decente farlo era, in realta', un posto da professore a contratto. Piu' prestigioso di quel che sono io, ma pur sempre un precario.
Fine parentesi lollosa. (Ne' io ne' lui fummo minimamente presi in considerazione per quel posto.)
Quando c'e' l'interview (per i posti fissi c'e' sempre), la cosa verte sulla propria attivita' di ricerca passata e su quello che si vorrebbe fare nel futuro. La cosa sembrera' ovvia a chi lavora nel privato, ma e' sempre sorprendente per chi viene dal mondo della ricerca italiana.
In Italia infatti i concorsi (per il posto da ricercatore si tratta di due scritti e un orale, oppure scritto, prova pratica in laboratorio, orale) vertono sulla conoscenza di base del candidato, piu' parte dell'orale dedicata alla descrizione della sua ricerca in corso (che pero' deve essere usata come punto di partenza per altre domande di conoscenza generale del campo). Sono rari i posti per discipline specifiche e piu' frequenti quelli per classi concorsuali molto generiche, come "fisica generale" (per il motivo di base che le universita' hanno un fabbisogno maggiore di persone che insegnino materie comuni a piu' facolta', e piu' popolose, e fisica generale e' insegnata in tutti i corsi di laurea scientifici mentre "fisica delle particelle" no). Di conseguenza, a ogni concorso ogni candidato che non voglia fare brutta figura passa un paio di mesi a ripassare concetti di base di primo o secondo anno d'universita'(**). Siccome questo sottrae tempo al lavoro vero, solitamente i datori di lavoro stranieri non apprezzano moltissimo (e non conoscendo il sistema non lo capiscono).
In Italia il sistema e' pensato in un modo che io trovo ideale, per vari motivi, e che e' tradito. Il legislatore si e' impegnato nel rendere il concorso il piu' blind possibile: durante gli scritti, tutti i candidati devono essere anonimi (scrivono i nomi in una busta piccola, da inserire nella busta grande con l'elaborato, che sara' aperta solo dopo la correzione); devono usare penne identiche, fornite dai commissari; se un candidato chiede un foglio in piu', tutti i candidati devono avere fogli in piu'; qualunque segno strano sui fogli puo' essere causa di esclusione, se ci sono motivi fondati di ritenere che sia un messaggio in codice per farsi identificare da un commissario; all'orale, idealmente (ma non nella pratica) le domande dovrebbero essere il meno ad hoc possibile, con l'unica eccezione del momento in cui il candidato deve descrivere la sua attivita' in corso; ma soprattutto, la valutazione non puo' essere basata sul tipo di ricerca in corso o passata, perche' non bisogna avvantaggiare chi lavora con qualcuno piuttosto che con qualcun altro. E invece, l'intera essenza (reale) del sistema di selezione italiano e' basato sul lavorare con le persone giuste.
Chi e' esterno al sistema, o e' interno ma intravede che potrebbe beneficiarne, tende a dire che tutto sommato gli sembra giusto: nel settore privato si sceglie ad personam, anche nella ricerca all'estero si sceglie ad personam, ed e' semmai il meccanismo del concorso ad essere anacronistico e inadatto. Se i concorsi italiani seguono criteri di giudizio arbitrari poco importa, visto che tutto il mondo e' arbitrario.
Ci sono pero' due problemi:
- Primo problema: il sistema e' ipocrita. E uno puo' dire ok, il sistema e' ipocrita, e allora? E allora, questo ha anche conseguenze pratiche a mio avviso: all'estero o nel privato, la valutazione e' arbitraria ma trasparentemente arbitraria: chi assume qualcuno se ne prende la responsabilita' (e di solito anche l'onere, ovvero lo stipendio del neoassunto proviene da fondi assegnati alla persona che lo ha scelto, mentre in Italia lo stipendio viene erogato centralmente). Le degenerazioni descritte nella prima nota di questo post sono possibili solo in un sistema in cui chi seleziona non riceve danni da una sua cattiva scelta, come appunto in Italia.
- Il secondo problema e' che, a mio avviso, il concorso blind all'italiana sarebbe davvero una ottima idea, se applicata realmente. La scienza e' tanto piu' a rischio di conformismo quanto piu' i selezionatori valutano i candidati in base a cio' su cui lavorano. Una ricerca "eretica" o semplicemente fuori moda e' possibile solo da parte di chi ha un posto fisso e non ha quindi nulla di serio da perdere. Un precario, ovviamente, ha tante piu' opportunita' di lavoro quanto piu' fa ricerca alla moda. Considerata la celebre curva di produttivita' che ha il suo picco attorno ai 30 anni, e il fatto che lo standard mondiale e' essere post-doc fino a 35 anni in media, e' facile trarne conclusioni. (Infatti i posti fissi contemplano solitamente doveri didattici e anche di amministrazione, e doveri impliciti di coordinamento del lavoro altrui, perche' non ci si aspetta che si lavori davvero, ci si aspetta che si sia dei leader.)

Testi e note:
(*) Altra specificita' del mio campo: pur essendo mafiosissimo, ma lo sono tutte le discipline indifferentemente in Italia, e' anche meritocratico. E' estremamente raro che chi raggiunge l'agognato posto fisso non sia molto bravo (anche se non e' necessariamente il PIU' bravo, e quando capita che lo sia e' comunque un caso). Infatti, anche se nei concorsi il merito non ha di fatto alcun ruolo (contano solo le alternanze tra gruppi afferenti alle diverse baronie), durante gli anni del precariato la scrematura e' abbastanza severa, perche' i padrini universitari hanno fondi limitati e tutto l'interesse a tenere solo quelli che valgono la pena.
Uno dei motivi per cui in altri campi sia normale che i favoritismi siano per parenti e amanti dei baroni (e, in subordine, per chiunque capiti nella coorte, foss'anche un ex laureando un po' scemo) e in altri campi siano prevalenti i sani interessi del gruppo e' probabilmente attribuibile alla diversa internazionalizzazione tra le diverse discipline. Quando sei in competizione con gruppi stranieri, come nella maggior parte delle discipline scientifiche, stai ben attento a non promuovere imbecilli. Quando invece ti interessa solo il potere locale, far diventare senatore un cavallo fa risaltare maggiormente la tua arroganza e, quindi, incute in tutti rispetto per il tuo Potere.
(**) Mi e' capitato di recente che una collega piu' grande, diventata ricercatrice quando io ero ancora studente, mentre le spiegavo una cosa che aveva radici in una nozione abbastanza "da pivelli" da poter essere dimenticata negli anni, dicesse per giustificarsi "eh, queste cose le ho studiate l'ultima volta per il concorso e poi basta piu'!", lasciandomi di sasso perche' sottintendeva che aveva fatto un solo concorso nella sua vita, quello che aveva vinto. Io, per non farla sentire a disagio per la sua ignoranza di quel concetto, dissi invece "be', io invece me lo ricordo bene perche' faccio in media due concorsi l'anno", mettendola in imbarazzo. (Se mi leggi: non era mia intenzione, volevo solo sdrammatizzare.)
(Incidentalmente, sul tema della precarieta' vi segnalo "La rivoluzione precaria - La lotta dei giovani francesi contro il CPE", di Antonio Sciotto e Anna Maria Merlo, donatomi da uno degli autori che qui ringrazio. Parla del caso francese, ma esso e' sufficientemente simile a quello italiano da permettere paragoni sensati e fare insomma capire che ci stiamo dirigendo verso la catastrofe e non c'e' proprio nulla da fare.)